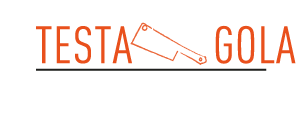C’era una volta il pensiero unico. E il modello unico. Per anni, per decenni abbiamo creduto che il massimo dell’innovazione e della modernità fosse l’intensivizzazione del sistema produttivo. Gli economisti raccontavano di aumentare la produzione il più possibile, ma riducendo contemporaneamente i costi. Tanto poi ci pensava la scienza a dimostrare, dati alla mano, che si poteva fare quantità senza compromettere la qualità. Anzi, c’era un evidente miglioramento. Tutta questa materia prima bisognava venderla e per questo i produttori chiesero e pretesero un prezzo unico e garantito. Quindi, al modello produttivo intensivo si affiancò il metodo di pagamento unico e uguale per tutti. Tanto la materia prima è tutta uguale. Di qualità, beninteso.
Ma noi producevamo a costi più alti dei nostri concorrenti esteri. Che fare? Come difendersi dalla concorrenza straniera, più agguerrita della nostra? Semplice: se noi siamo bravi, ma solo più sfortunati, perché abbiamo poca terra, e se tutto quello che facciamo è di qualità, difendiamo l’italianità esaltando tutto quello che avviene nei confini patri. Da quel momento abbiamo coniato e ostentato termini fino ad allora usati con maggiore pudore. Abbiamo preso in prestito dalla Francia il termine terroir, ci siamo inventati i marchi territoriali, tutto è diventato tipico, locale, a km zero. Non contenti, ogni tanto si bloccavano alle frontiere il latte, la carne, il grano, il riso. Anzi è di questi giorni la notizia che l’UE ha messo i dazi al riso proveniente dalla Cambogia. La ricca pianura padana ha preteso i dazi al riso prodotto nei paesi poveri, aggravando ancora di più i problemi di quelle popolazioni!
Quindi allo stato attuale il modello è ancora in posizione dominante: il prezzo è unico per tutte le materie prime e non è legato alla qualità. Si paga un tanto al chilo. Insomma, l’agricoltura è rimasta l’ultimo baluardo del comunismo più ortodosso.
In verità l’agricoltura non è rimasta proprio immobile. Per provare ad offrire un minimo di diversità, ci siamo inventati le razze, le varietà vegetali. Niente di male, se la scelta fosse stata dettata da esigenze locali, per le capacità che hanno alcune razze o varietà di adattarsi ai microclimi ed a specifici areali. Pessima invece la pretesa di indicare questi ecotipi come responsabili della superiorità dei prodotti che da essi ne possiamo ricavare. Quando Mussolini annunciò, nella piazza di Trieste, le leggi razziali le motivò dicendo che non solo “siamo convinti della diversità ma anche della superiorità della razza ariana”.
Poi c’è il filone biodinamico e biologico. La scienza ufficiale li ha guardati sempre con sospetto. I biodinamici vengono sempre considerati come soggetti strani, che rimangono aggrappati a riti esoterici. Ultimamente gli attacchi si stanno facendo violenti. Ha preso l’iniziativa Elena Cattaneo, che in un articolo su D di Repubblica dell’agosto scorso ha scritto, in sintesi, che il biologico non è vero che è meno inquinante e comunque, poiché le produzioni sono più basse di quello intensivo e la popolazione è in aumento, la fame è alle porte. Pensavamo di esserci liberati di Malthus e invece ce lo ritroviamo in un periodo in cui un giorno sì e pure l’altro c’è qualcuno che scrive di sprechi alimentari.
Peggio è capitato al biodinamico. Quest’anno l’Università di Milano ha concesso i propri locali per la conferenza annuale della loro associazione e subito molti professori si sono sentiti in dovere di protestare per aver dato credibilità scientifica ad un settore che non lo merita.
Il pensiero, ed il modello, rimangono unici e non si discutono.
Ultimamente però un altro pensiero unico si sta facendo strada. Gli animali inquinano, le colture vegetali si riescono a produrre solo con un intervento massiccio di erbicidi e concimi di sintesi, oramai i trattamenti si fanno con i droni, a tappeto e su tutto. Ed ecco il modello alternativo. Sempre unico. Su La Lettura n.371 del 6 gennaio i giornalisti Monti e Redi scrivono un articolo dal titolo” Le staminali vegane” e i cui sottotitolo è sufficientemente eloquente:” l’allevamento degli animali per produrre cibo causa danni molto gravi all’ambiente e viene criticato duramente sul piano etico. Un’alternativa straordinaria è ricavare carne delle cellule staminali coltivate e differenziate. Questi burger in vitro evitano sofferenze agli esseri viventi e giovano agli equilibri ecologici del pianeta. Già varie imprese importanti stanno investendo nel settore”.
In campo vegetale le cose non vanno diversamente. Giorni fa ho visto un servizio su Rai 3 su un’azienda americana che produceva ortaggi in idroponico. Capannoni enormi, piani sopraelevati per un’altezza di 10 metri, senza terra e tutto sotto controllo. Il produttore si vantava che in questo modo non c’era bisogno di trattamenti di alcun tipo e la qualità era elevata.
Ecco, la qualità. Tutti dicono di fare qualità, il modello resta sempre lo stesso. Ma se tutto è uguale, posso benissimo dire che quella qualità è pessima. Tanto non ho il confronto. Ma quel che è peggio, non sappiamo cosa sia la qualità. Se escludiamo il mondo del vino, che sta avanti anni luce, nell’intero sistema gastronomico noi non abbiamo la chiave di lettura della qualità. Se un grano si sceglie in base alla proteina e questa non ha alcuna relazione con l’odore e il sapore e nemmeno con il valore nutrizionale, allora se quel pane o quella pasta avranno un profumo, un sapore, sarà dovuto al caso. Tutto avviene all’insaputa del produttore e dell’acquirente.
Insomma il modello unico ci ha portato laddove esattamente era prevedibile che arrivassimo: la non conoscenza dei fattori che determinano la diversità e le molecole che ne sono responsabili.
Un esempio è il sapore. Cosa è il sapore? Se io voglio misurare il sapore della pasta, del prosciutto, della patata, che molecole analizzo?
Ma siamo arrivati alla fine dell’articolo. Il seguito al prossimo.

Ha diretto per oltre trenta anni il CRAE di Bella, Italia. Si è occupato di sistemi pastorali in particolare ha studiato la relazione fra erba e qualità del latte e dei formaggi. Ha fondato Anfosc, Associazione nazionale formaggi sotto il cielo, di cui è oggi Presidente e la rivista Caseus.
Attualmente è impegnato sul Metodo Nobile, che ha ideato, messo a punto e che sta provando a sviluppare in diverse aree del mondo.