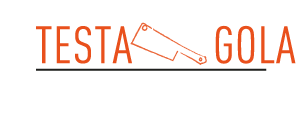Vimodrone, nebbia, 1978. La carriolata di pasta con la piovra, che la moglie di Carlo ci aveva preparato col peperoncino fresco, era affogata in una cisterna di Tocai del Collio, ma è stato il caviale a farmi male e c’è voluta tutta la bottiglia di vodka che avevo portato in treno dalla Polonia per pisciarlo sui gerani della recinzione. Carlo nel chiudere la porta cadde sulla moglie (stavolta senza volerlo proprio), mentre io inciampai nella ciotola del cane perché non avevo centrato bene il vialetto del giardino e non distinguevo una zucca da una zecca. Non so come ha fatto quella carogna del cancello a spalancarsi da solo con un zzzzt di rumore strano e mi son ritrovato in uno di quei tappeti grigi che si chiamano strade. Chiamala strada, te… era un garage all’aperto, altro che balle. Quando passavano con l’autopompa a pulire le strade di notte, tutte le macchine se ne stavano appollaiate sul marciapiede, una 2 CV anche in verticale. Era di Carlo: lui pesava 120 kg ed era cintura nera, ma la poverina pesava solo qualche quintale, per giunta aveva un animo musicale, dato il motore, quindi non poteva certo fare storie se non si trovava tutto lo spazio per farla molleggiare ad ogni scoreggia. Perciò, in piedi! Un pidocchio che m’ero beccato fra i capelli mi suggerì di imboccare la prima traversa: di solito se puliscono una strada non puliscono le sue traverse. Era proprio quella del tram per la Gobba, che culo! Un sacrosanto pavé per la coppia di rotaie, ma un marciapiede da stadio, anzi da giro d’onore della banda del paese con le bandiere (e le gonne delle majorettes) al vento. Tiro dritto, ma vado verso il bordo, verso la strada, pendo a sinistra. Allora tiro a destra, mica son scemo, verso il muro. Rien à faire. Pendo sempre a sinistra. Mi fermo. Metto il piede a destra, guardo il muro e muovo l’altro piede. Niente: sempre giù da quel canchero del marciapiede. Un piede sul marciacacchio ed uno in strada, era l’unica soluzione, così ero sicuro di andar dritto. Ho fatto tre passi e poi tutti e due i piedi devono essersi messi d’accordo per preferire il pavé e si erano abbracciati per strada. Bastardi. Sta arrivando quella cosa verde che sferraglia tutta illuminata… il tram!

Notte, nebbia, nessuno in strada, ostia che bel problema! Se osavo mettere un piede sul marciastronzo mi ritrovavo in mezzo alle rotaie, porca sidella! E allora l’idea geniale, eccola lì che usciva come quel mostro dalla nebbia: stai fermo. Anzi, siediti sul marciavaffa. Detto, fatto. Mi son seduto e quel porco del tram, l’ultimo della notte, non si è fermato. “Fermata a richiesta”, dovevo pure ricordarmelo, accidenti, invece stavo seduto e mi tenevo le gambe per non farle muovere verso il centro della strada, come cavolo potevo segnalare l’intenzione di salire? Allora mi sono alzato, l’ho inseguito, chissà perché in mezzo alle rotaie quelle maledette andavano via dritte, tanto dritte che a momenti l’acchiappavo… e ho sentito stridere i freni, mammamia! Si aprirono le porte e vidi la scaletta. Il conducente bestemmiò qualcosa, ma non l’ascoltai. Arrivò un tizio che aveva un catino in testa e il suo bravo faro antinebbia, chissà, uno di quelli delle autobotti, mi diede una spinta e riuscì a buttarmi sul tram. Fu allora che capii cosa voleva dire “un tram chiamato desiderio”.

Di quelli verdi. L’arancione non mi è mai piaciuto. E capii anche dove porta la vodka. Scesi dal tram dopo la Gobba, con la nebbia gelata che mi frustava la faccia. C’era una gran luce in fondo a quei casermoni, le grandi porte a vetri e la portineria vuota. Meglio così: niente bisbigli né sorrisini di scherno. Son sparito nella tromba delle scale e ho cominciato a litigare con le tasche per tirar fuori quello che non volevano mollare: le chiavi. L’incubo delle tenebre (per via delle luci che si accendono automaticamente al passaggio, ma si spengono inesorabilmente dopo trenta secondi), ecco, quell’incubo mi stringeva nella sua morsa. Porte sprangate, per giunta blindate, ma alla fine eccole, le maledette e alla fine anche il diavolo riuscì a entrare in quella serratura. Venni naturalmente scoperto da una specie di sacco della biancheria in vestaglia da notte che sembrava un pipistrello per quanto si agitava. Era la compagna di viaggio dei miei amici polacchi che dormiva sotto l’attaccapanni, mentre loro mi stavano certamente saltando sul letto matrimoniale una decina di metri oltre il corridoio. Bionda, con gli occhi azzurri, volevo farci qualsiasi cosa, anche l’amore, ma fu più forte di me e mi portò in cucina. Ho sempre temuto l’inquisizione. Invece, per nulla turbata, con quella voce che riusciva a contagiare perfino i miei monosillabi di risposte incomprensibili, aprì il frigorifero e con quella bocca crudele che aveva mi chiese: “Una vodka per dormire, kolego?”…

Di formazione tecnica industriale è stato professionalmente impegnato fin dal 1980 nell’assicurazione della Qualità in diverse aziende del settore gomma-plastica in Italia e in alcuni cantieri di costruzione d’impianti nel settore energetico in Polonia, dove ha promosso la cultura del vino attraverso alcune riviste specialistiche polacche come Rynki Alkoholowe e alcuni portali specializzati come collegiumvini.pl, vinisfera.pl, winnica.golesz.pl, podkarpackiewinnice.pl e altri. Ha collaborato ad alcune riviste web enogastronomiche come enotime.it, winereport.com, acquabuona.it e oggi scrive per lavinium.it, nonché per alcuni blog. Un fico d’India dal caratteraccio spinoso e dal cuore dolce, ma enostrippato come pochi.