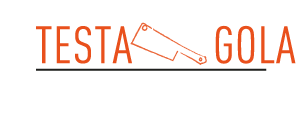DOCG, DOC, DOP, IGT, IGP, STG.
Sigle, che hanno un minimo comun denominatore: certificare la qualità controllata di cibi e bevande made in Italy, come garanzia, contro i tentativi di contraffazione. Sigle che rimandano tutte ad un concetto fondamentale: la valorizzazione e la tutela del territorio di origine di questi prodotti, attraverso la salvaguardia della sua storia e delle sue tradizioni.
Di qui, un primo aspetto del termine territorialità ci viene immediatamente fornito, in relazione a quello più affine di territorio, inteso cioè come spazio, luogo, in cui si viene ad agire. Un risvolto di tipo statico, insomma, fisicamente limitato. Tuttavia, a pensarci meglio, lo stesso termine può assumere, in senso lato, un significato molto più ampio, e soprattutto dinamico, di interazione, tra l’individuo e il suo territorio, tra individui appartenenti a territori differenti, e dunque tra gli stessi territori.
Ci rendiamo quindi conto del bagaglio di possibili interpretazioni che il concetto di territorialità porta con sé. Cercheremo, in questo portale, nato col fine di sondare e valutare il settore prettamente enogastronomico, di riferire le nostre considerazioni in merito allo specifico ambito di una territorialità di tipo alimentare, con tutte le annesse variazioni sul tema.
Innanzitutto, quando si parla di territorialità alimentare è d’uopo rivolgersi alla Istituzione dei presidi.
I presidi rappresentano prodotti agroalimentari, soprattutto agricoli, tutelati mediante uno specifico disciplinare. Sono stati fondati a partire dal 1999, a Bra, nel cuneese, ed oggi se ne annoverano, a livello mondiale, 513, di cui ben 271 solo in Italia.
Sono conosciuti da tutti con la specificazione inglese di “slow food”, ed hanno lo scopo di salvaguardare le piccole produzioni di eccellenza – ovvero di nicchia – minacciate dall’omologazione industriale. In tal senso, tra gli obiettivi perseguiti, c’è la negazione degli OGM, la protezione delle api, la predicazione dello “slow fish” e della “slow meat”, la conservazione dei semi, il controllo dell’etichetta e la resistenza casearia. Inoltre, al centro delle strategie della Istituzione c’è la difesa della biodiversità, dal più piccolo ed elementare esemplare vivente, passando per le specie animali e vegetali, per arrivare al più grande e complesso ecosistema. In una parola, biodiversità come territorialità sostenibile.
Facciamo un esempio
Prendiamo in esame le malghe, e cioè il pascolo delle greggi e delle mandrie in zone collinari o montane – e tutto ciò che ne consegue, dalle attrezzature ai fabbricati, quali casere, baite, stalle, rifugi, alla lavorazione del latte – prima di affrontare la migrazione stagionale verso la pianura.
Il sistema malga può senza dubbio essere considerato biodiversità a carattere prettamente territoriale. Ma cosa succede se scompare questo sistema? Scompaiono le razze di vacche e di capre domesticate dall’uomo, scompaiono i prodotti altamente genuini derivati dalla lavorazione rigorosamente a crudo del loro latte – ricordiamo che le mandrie e le greggi al pascolo sono libere di scorrazzare sui prati, di nutrirsi con erbette selvatiche e soprattutto di scandire le ore del pasto, del riposo, e soprattutto della riproduzione a loro piacimento -, scompare, insomma, una tradizione secolare strettamente legata al territorio. In tal senso, il concetto di territorialità assume senza dubbio una connotazione di tipo statico.
Tale connotazione rimanda, per di più, ad un’altra importantissima realtà odierna, che sta prendendo sempre più piede: quella rappresentata dal km 0.
Il km 0
E’ un tipo di commercio nel quale i prodotti vengono commercializzati e venduti nella stessa zona di produzione al fine di risparmiare, in termini economici, e soprattutto di inquinamento e impatto ambientale, nel processo di trasporto logistico del prodotto.
Tale sistema garantisce la biodiversità territoriale in quanto si oppone alla standardizzazione del prodotto industriale. Per cui vade retro insalatine di misticanza confezionate, e lunga vita all’insalata del vicino contadino, o, meglio ancora, del nostro orticello fatto in casa. Anche se un cittadino newyorkese, ma anche più semplicemente napoletano, potrebbe avere non poche difficoltà a reperire prodotti a km 0, ma forse è per questo che nelle grandi metropoli hanno inventato gli orti urbani!
La pizza napoletana
Cambiamo rotta per un momento e consideriamo tutto ciò che territoriale in senso stretto non è e soprattutto non può essere. Prendiamo, ad esempio, gli ingredienti di uno dei prodotti più diffusi al mondo: la pizza napoletana, dal 2010 Specialità Tradizionale Garantita dall’Unione Europea e, dal 2011, candidata al riconoscimento UNESCO come Patrimonio Immateriale dell’Umanità.
Due sono le varianti di condimento previste dalla tradizione della cucina napoletana: marinara e margherita. Per cui all’impasto base – acqua, lievito di birra, sale, farina – vengono aggiunti pomodoro, aglio, origano e olio evo, per la marinara; pomodoro, mozzarella di bufala o fior di latte, basilico, olio evo, per la margherita.
E dunque. Posto che praticamente tutti gli ingredienti della pizza napoletana appartengono al territorio, a qualcuno di essi nel tempo è stato concesso pure il presidio, e per molti possiamo parlare di km 0; si dovrebbe tuttavia riflettere sulla provenienza di un prodotto, in particolare, che tanto territoriale non è, e cioè il pomodoro.
Importato in Europa dalle Americhe nel 1540, si diffuse in Italia, ed in particolare al sud, solo dopo la seconda metà del XVII secolo. Ma l’aspetto più interessante è che il colore originario del pomo, d’oro per l’appunto, non è quello con cui lo conosciamo noi adesso, frutto invece di selezioni e innesti ripetuti. Stesso dicasi per le patate, le melanzane, le zucchine, i peperoni e i peperoncini – tanto per citare comuni ortaggi entrati a far parte del nostro consumo quotidiano – e l’elenco potrebbe continuare a lungo perché in effetti la maggior parte dei prodotti agroalimentari, di larga diffusione e coltivazione, autoctona non lo è mai stata.
S’insinua, in questo caso, il significato di una territorialità dalla connotazione dinamica, d’interazione, come suddetto, tra territori differenti.
Basti pensare all’uva
Oggi c’è un gran parlare di vitigni autoctoni, originari (dal greco autòs = stesso) del territorio di provenienza (dal greco chthòn = terra). Ma quanto può valere, anche in questo caso, il termine autoctono per una pianta, come quella dell’uva, che, dopo l’avvento devastante della fillossera, non viene più impiantata su piede franco se non in particolarissime condizioni territoriali? Quello dell’innesto su tralci di vite con radice americana è un vero e proprio trapianto e, come tale, assolutamente non territoriale.
D’altra parte, non trascuriamo l’iniziativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Ministero Agricoltura e Foreste, i quali, nei primi anni ’70 hanno dato il via alla cosiddetta selezione clonale, tecnica che ha posto come obiettivo quello di fornire alla viticoltura nazionale materiali, vitigni e portinnesti, sicuri dal punto di vista sanitario. Ad oggi, un gran numero di selezioni sulle diverse varietà è stato effettuato, riducendo, di fatto, la variabilità genetica presente in natura e omologando così le caratteristiche delle uve.
Il Sangiovese, ad esempio, è la varietà più clonata d’Italia. Ne esistono circa 22 cloni omologati e altri 4 in via di omologazione. Come si fa, anche in questo caso, a parlare di territorialità in senso stretto?
E infine veniamo all’uomo
Forse, più di ogni altro prodotto finito, la più importante espressione del concetto di territorialità. Stanziale fin dalla nascita, esso diviene nomade nel corso della vita, al fine di esplorare lo spazio fisico in cui si trova a camminare.
Prendiamo in prestito, a tal riguardo, le più recenti concezioni del sociologo polacco Z. Bauman sull’uomo come cittadino globale: il comun denominatore del nostro pianeta, oggi, è la cosmopolitizzazione, che sta ad indicare la cessazione dei confini che da sempre si frappongono tra mercati, stati, civiltà, culture ed esperienze. Il termine frontiera, dal punto di vista degli scambi e delle interazioni di informazioni e capitali, è divenuto quasi del tutto obsoleto, sebbene la questione dell’immigrazione sembri sussistere come ultima forma di ostacolo al flusso delle persone.
Ebbene, si può ancora parlare di territorialità dell’individuo in quanto appartenenza al territorio di origine? Se l’uomo è tale da essere contaminato dall’irreversibile processo di globalizzazione in corso perché dunque non dovremmo accettare anche le conseguenze della stessa sulla massificazione dei prodotti alimentari di uso e consumo?
La questione etica che ne discende è profondamente complessa.
Vero è, tuttavia, che le nostre abitudini alimentari sono molto cambiate, se pensiamo che prodotti come la tapioca, la salsa di soia, la quinoa, tanto per citarne qualcuno, sono entrati definitivamente nella nostra alimentazione quotidiana.
In pratica, si è a poco a poco sviluppata e radicata una territorialità alimentare a connotazione fortemente dinamica, e, contemporaneamente, una territorialità alimentare di tipo esclusivamente statico sembra, ora più che mai, resistere e permanere, senza che l’una invada il campo dell’altra.
Non è forse questa un’espressione di dialogo rappresentativa per un’efficace convivialità tra i popoli? Certo è che se anche tra i popoli s’iniziasse a diffondere questa pacifica dialettica, il termine territorio, e la sua forma sostantivata territorialità, non sarebbero più ricondotti a quello di terrore, come si affermava, nel 534 d.C., nel famoso Codice Giustiniano.