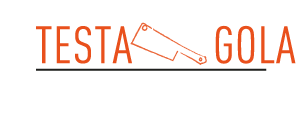Dal libro ”Sulle tracce di don Mario Crenna”, in cui il suo allievo Mario Crosta racconta la storia di questo sacerdote insegnante di religione ai ragazzi di un Istituto Tecnico Industriale statale e che ho avuto l’onore e il piacere di spedire anche all’indimenticabile vescovo di Acerra, sua eccellenza mons. Antonio Riboldi, ho estratto il capitolo relativo al suo rapporto con il vino.
Mi sembra interessante proporvelo qui poiché questo libro non è in vendita e potreste scaricarlo in versione PdF, come altri suoi scritti anche dalla pagina del progetto di fondazione dei suoi amici che lo riguardava, in seguito alla sua morte avvenuta nella notte del 5 gennaio 2012 all’età di 88 anni, ma che non viene più aggiornata.
Rolando Marcodini
Siete voi le viti di cui mi sento uno dei tralci?
Tutti i grandi sono stati bambini, una volta.
Ma pochi di essi se ne ricordano.
(Antoine De Saint-Exupéry)
Vita sana e all’aria aperta, in una natura che favorisce le compagnie, i gruppi, le bande, ma poi… tutti a involarsi nelle scorribande per le risaie o per le vigne: questa era la goduria maggiore del periodo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70.

Vigne dove i preti non mancavano. Certi preti. Se pensate che i preti siano tutti uguali, vi sbagliate, anche di grosso: non avrete conosciuto il Don Crenna. E non crediate che fosse l’unico. Bisogna ricordare anche Don Giuseppe Cogno, un vero pastore di anime con il bernoccolo del vignaiolo, che nel 1961 fondò la Cantina del Parroco di Neive, anche lui nato nel 1923 come Don Crenna, ma a Novello, vicino a Barolo. Che la ’23 fosse un’ottima annata di preti?
È difficile, comunque, che su questa terra qualcuno dia dei premi o dei riconoscimenti per il vino a un prete, anche se poi si usano le antiche chiese, costruite appunto dai preti, per ricavarne delle pittoresche enoteche, proprio come quella regionale del Barbaresco.
In questo ottimo vino, va detto, c’è appunto anche l’opera di quel Don Giuseppe Cogno che negli anni sessanta fu nominato parroco della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo a Neive.
Col tenace sangue langarolo che aveva, appena arrivato si interessò subito per ottenere l’insediamento della scuola media in paese (anni dopo inaugurò anche la scuola di arte bianca, mettendo a disposizione i locali della parrocchia). Per convincere i giovani a restare a lavorare la terra, invece di emigrare verso i miraggi della grande città, non esitò a utilizzare le vigne parrocchiali, producendo vini di alta qualità.
Buon sacerdote, ma anche dinamico imprenditore, diede lavoro a sempre più persone, facendo della sua bella azienda un’occasione di sviluppo per la viticoltura di tutta la zona e rendendola famosa in tutto il mondo per il suo vino, circa 90.000 bottiglie l’anno tra Barbaresco, Dolcetto e Barbera. È venuto a mancare il 13 gennaio del 2000, circondato dalla stima e dal rispetto dei neivesi per la sua gran voglia di fare e la sua concretezza, che hanno reso Neive uno dei luoghi di elezione del famoso Barbaresco.
Pensate che il Don Crenna non fosse altrettanto impegnato a fare un vino come Dio comanda?
Pensate che non abbia girato per le stradine più contorte del Piemonte (ma non solo!) per andare a vedere appunto come gli altri sacerdoti in vino veritas, benedetti pure loro, riuscissero a estrarre dalle uve qualcosa che fosse degno di diventare il sangue di nostro signore Gesù Cristo? Prendeva la sua NSU Prinz e via! Non tornava mai a mani vuote. Nelle sue vigne ha piantato anche ceppi di Chasselas, un vitigno che soltanto chi si è arrampicato fino sulle pareti scoscese del Canton Ticino sa bene che cos’è.

Perciò, quando entrate in una chiesa di un territorio vinicolo d’eccellenza del nostro Paese, accendete un cero affinché il cielo ci ascolti e che ce ne mandi più spesso di questi sacerdoti con la passione per le terre da vino, di poche parole e tanti fatti, che ce n’è davvero un gran bisogno nel mondo vinicolo odierno, ormai viziato e scombussolato da troppe chiacchiere e da troppe mode, vero Alberto?
Il nostro Don ha sempre fatto il vino con le sue uve fin dal 1958, fin da quando tornò da Roma e cominciò la sua simbiosi con la sua terra e la sua vigna, che riuscirà a portare a un’estensione di più di 600 piante nel 1975, conducendone in seguito per un po’ perfino un’altra a Cavenago, sopra Ghemme, che dovette mollare per i troppi impegni e una violenta grandinata.
La vigna sopra casa sua, infatti, lo assorbiva già moltissimo, anche perché la gestiva da solo per quasi tutto l’anno. Soltanto ai primi di marzo, all’inizio della potatura, veniva talvolta aiutato da qualche amico o conoscente, ma soltanto per fare un po’ d’ordine e raccogliere i tralci recisi, ormai diventati sarmenti, cioè legno vecchio. Per il Don era un lavoro lungo a cui si doveva però prestare la massima attenzione: ne andava di mezzo il raccolto se il taglio non veniva eseguito nella posizione giusta. C’era poi il paziente lavoro della legatura e qui era davvero sorprendente vedere con quanta cura e delicatezza prendeva ogni tralcio a frutto tra le sue robuste dita in quelle manone fortissime. Lo piegava quel tanto che bastava a fissarlo al fil di ferro di sostegno con un legaccio in corteccia fresca di salice (quello rosso, più flessibile e robusto di quello giallo) sapientemente annodato.
A volte, a causa di ritardi dovuti alle sue molteplici attività, su alcuni dei tralci da legare si trovava qualche gemma a frutto già molto pronunciata e allora l’attenzione del Don raddoppiava: bisognava vedere con quanta delicatezza e abilità legava abbastanza largo per non staccare quella gemma che, secondo lui, avrebbe prodotto un bel grappolo d’uva… Poi, molto più in là nella bella stagione, quando non se ne poteva proprio fare a meno, c’erano le irrorazioni con soluzioni a base di solfato di rame ed ecco che lo si vedeva viaggiare avanti e indietro tra quei filari con la pompa in spalla, una meticolosità certosina e un passo costante.
E finalmente la vendemmia.
Questa sì che era una festa e vi partecipavano parenti e amici. Il Don metteva allora in funzione quella funicolare che aveva contribuito a costruire con suo padre e dalla sommità della collina inviava in basso le ceste piccole, dove adagiava delicatamente i grappoli delle uve dalla buccia più delicata per non provocare la rottura degli acini più maturi e innescare involontariamente una fermentazione spontanea sotto il sole, quindi le “benne” (gerle di metallo o di plastica) delle uve con la buccia più robusta, mai riempite fino al bordo per non schiacciare gli acini, che giungevano velocemente nel cortiletto di casa.
Il Don poi le versava nella macchina diraspatrice, che separava gli acini dai graspi per poi convogliare il mosto direttamente nelle tine, dove cominciava a bollire appunto per via dell’innesco della fermentazione, provocato dal contatto dei lieviti naturali presenti sulla parte esterna delle bucce con la polpa, cominciando così il processo di vinificazione, all’ombra e al fresco della cantina.
Era un autodidatta appassionato nella pratica e un curioso incredibile in teoria.
Divoratore di libri qual era, già frequentando gli archivi vaticani è stato uno dei pochissimi ad aver letto anche il libretto sul vino di un altro prete che è diventato pure Santo, il fondatore dei Salesiani Don Giovanni Bosco, L’Enologo Italiano edito nel 1846 e scomparso ormai chissà dove, ma soprattutto il codice di Diritto canonico, durante gli studi alla Gregoriana. ”Vinum debet esse naturale de gemine vite et non corruptum”, così prescrive il canone 924 del Codice di Diritto canonico: il vino usato durante la Santa Messa deve essere naturale, frutto della vite e non alterato.
«Rosso o bianco?», gli chiesi una volta, visto che il sangue di Cristo non poteva certo essere di un colore diverso dal nostro, ma quando avevo fatto il chierichetto non mi era mai capitato di versare dall’ampollina altro che dei profumatissimi vini dorati da uve Moscato.
Il Don era molto chiaro in tutte le risposte che dava agli alunni e ci spiegava che il Diritto Canonico non si fossilizza sul colore del vino e non impone nemmeno determinati vitigni.

Anticamente il vino da Messa era sicuramente rosso, proprio per ricordare il sangue di Cristo al quale la liturgia si richiama e nel rito della Chiesa orientale è rosso ancora oggi.
Soltanto nel 1565, con il primo Sinodo di Milano, riconoscendo che il vino rosso può macchiare in modo un po’ troppo evidente i paramenti e gli arredi sacri bianchi, dalle tovaglie di lino o di canapa dell’altare fino al corredo di corporale, manutergio, palla, purificatoio e altri parati, venne autorizzato l’uso preferenziale di quello bianco. Così non ci sarebbero stati problemi se il sacerdote o il chierichetto ne avesse fatto gocciolare un po’ durante il sacrificio eucaristico.
Come ci diceva il Don, il vero problema è la produzione, che può essere fatta in vigneti e cantine gestiti da uomini e/o da ordini religiosi oppure da produttori laici, nel qual caso però si deve avere l’autorizzazione preventiva del Vicario foraneo e sottostare ai dettami del Diritto Canonico, con tanto d’imprimatur timbrato dalla Curia.
Domanda ”da cinque milioni” di un ex-allievo che scrive di vino da anni sul Web (perciò non ne rivelo il nome): «Un vino perfettamente naturale e non ”corrotto”, non manipolato, non alterato, non commisto a sostanze estranee, del tutto puro?».
Il Don rideva di gusto, perché capiva anche l’idealismo, ma faceva sempre i conti con la realtà della terra e della vinificazione, che non è un processo naturale della fermentazione dell’uva, ma avviene per intervento del genio dell’uomo che ne contrasta l’acidificazione conseguente all’ossigenazione della polpa, quella che inizia già negli acini che si rompono in cassetta durante la vendemmia e nei mosti torchiati anche nel modo più soffice che si possa usare. Questo intervento del genio dell’uomo, in questo caso il suo, non era poi così facile da definire allora e non lo è neanche oggi. Il concetto sulla carta è chiarissimo, eloquente, eppure, come sapeva perfettamente anche il Don (che un po’ di enologia la doveva pur masticare), non era per niente semplice da mettere in pratica, infatti ci raccontava che le più disparate Congregazioni Vaticane nel corso della storia hanno puntualizzato posizioni differenti.
Solo nei primi mesi dopo la vendemmia, a volte fino a Pasqua, si esprimevano al meglio anche i vini migliori delle suorine più innocenti e scrupolosamente innamorate di Cristo, ma più in là cominciavano a perdere freschezza e il sapore diventava acescente, stucchevole, putrido, soprattutto nelle chiesette dove officiava un solo prete, per giunta povero, e una volta stappata una bottiglia che costava una bella botta ci volevano magari anche due settimane prima di consumarla tutta, senza riuscire sempre a conservarla in modo ideale, specialmente d’estate.
E il Diritto canonico ha sempre imposto, giustamente, che il vino scadente, scaduto, non si potesse assolutamente usare per officiare la Santa Messa.
In certe annate storte il Don, per non buttar via quel vino dal cagionevole stato di salute a causa di un livello insoddisfacente di alcool, andava a comprarsi un po’ di metabisolfito e, facendosi il segno della croce, gliene dava un pizzico. Anche per l’uva usava l’accortezza del saggio, al massimo un po’ di poltiglia bordolese se vedeva insorgere malattie, ma riduceva all’osso le irrorazioni, stando sempre attento al decorso delle malattie per non doverne usare più del necessario.
Ha sempre fatto vini naturali, non soltanto perché obbligato dal Diritto canonico, ma perché la coscienza gl’imponeva di non manipolare il sangue di Cristo o rischiava di officiare una messa che lui sapeva certamente non valida, sebbene la gente non lo potesse neanche immaginare.
Rifuggiva però dall’estremizzarne la naturalezza, dal lasciare che il vino si facesse da solo, che potesse fermentare ancora in bottiglia, puzzare magari d’idrocarburo, oppure di uova marce e magari provocare diarree, come si suppone che avvenisse in passato ai quattro angoli del vecchio continente con certi vini fatti un po’ troppo bucolicamente dai monaci.

Aveva studiato a fondo la storia della viticoltura e dell’enologia nel suo territorio fin dal medioevo, riuscendo a far parlare tutti i documenti, a partire da quelli del censimento di quelle terre nel Cinquecento, come si può appurare dalla ricerca su Viticoltura ed enologia fattori storici per la nostra gente che fu pubblicata nel BSPN n° 2 del 2008. Scriveva il Don: ”quanto il vigneto primeggiasse localmente, ben al di sopra di ogni altra coltura, lo si deduce dalla bizzarra ostinazione con cui si giunse ad impiantare le viti persino nel grezzo isolotto ubicato entro una biforcazione del fiume Sesia, all’altezza del borgo” (di Romagnano Sesia), in quella vigna che nel 1497, in piena epidemia di peste, data l’ideale condizione d’isolamento della sua posizione «ultra Sicidam, inter duos ramos», veniva considerata in luogo il non plus ultra per allestirci proprio un miserevole “terminale” lazzaretto.
Nei suoi studi prendeva in esame tutto, non tralasciava nulla, se avesse potuto avrebbe citato anche i sassi con la posizione della cacchetta delle mosche, quindi anche in quella ricerca che spaziava su ben tre secoli (fino al rapporto del Commissario sabaudo Rochis al governo nel 1825) il Don sfoderò le sue unghie estraendo dalle documentazioni le cifre, gli argomenti e i temi che potessero far riflettere i vignaioli del posto. Fra l’altro, definiva una “griglia” la morfologia tipica del territorio novarese, per i condizionamenti alla coltivazione della vite imposti dalle differenze orografiche e geologiche, per esempio la variazione di posizionamento, di sistema d’impianto, di allevamento e di coltura, l’influenza di fattori ”diretti” quali la conformazione fisica dei terreni e la composizione chimica dei suoli a valle del Monte Rosa, drenaggio, esposizione, umidificazione, altimetria delle vigne.
Non tralasciava i fattori ”esterni” o concomitanti: la disponibilità di sostegni di castagno o di «spino» (acacia) per la palificazione, la prossimità delle brughiere, il cui sfalcio macerato contribuisce alle letamazioni triennali quando c’è anche la capacità economica di mantenere rifornite le stalle.
Non ultima la lunghezza dei cicli produttivi della vite, qui più lunghi di quelli di altre colture annuali, il che aumenta l’incidenza delle calamità naturali, diminuisce la produttività per più stagioni e determina il precoce invecchiamento delle viti. Sciorinando le vicende ed i rapporti storici riusciva a dare molti spunti anche a chi magari non aveva la passione per la ricerca storica e non s’infervorava nello spulciare i dati, cosa frequente nel caso di lettori neofiti o laici e piuttosto diffusa fra i lettori comuni e accidentali di qualche tomo che poteva anche pesare come un mattone.
Riusciva a infondere perfino un senso di appartenenza alla tradizione, come quando riportava fedelmente la nomenclatura, per esempio come in questo caso: “Perciò incontriamo in base alla economia di impianto: vigneti «spessi» (a spina di pesce), «distanti due trabucchi», «bassi»; per l’assetto sul terreno: «filagnati», «doppi», «a mezuli» (l’equivalente di: filari a spalliera, sistema maggiorino, e nell’aratorio ”cassoni” intercalati con altre colture); per il metodo d’espansione: «a forzone» (o piantale), «a scarione», «a quattro e a otto coazze», «a sarro» (con riscontro ai nostri sistemi di potatura corta o lunga); per la collocazione dell’appezzamento: «al basso», «in costa», «in monte», «affacchiata», «che s’abrazza», «a ronco», «a mo’ di ronco», «a ronco a coltello» (che ricorda i nostri ”a girapoggio”, ”a spina”, ”a rittochino”, ”a terrazze”)”.
Se riuscirò a raggiungerti nella tua nuova vigna in Cielo, caro Don Crenna, mi potrai pure strapazzare per quello che sto per scriverti: in vigna e in cantina avrai pure faticato tanto, ma ti sei divertito proprio come un bambino. Dixi et salvavi animam meam!
Mario Crosta

Ha smesso di giocare in cortile fra i cestelli dei bottiglioni di Barbera dello zio imbottigliatore all’ingrosso per arruolarsi fra i cavalieri di re Nebbiolo e offrire i suoi servigi alle tre principesse del Monte Rosa: Croatina, Vespolina e Uva Rara. Folgorato dal principe Cabernet sulla via dei cipressi che a Bolgheri alti e stretti van da San Guido in duplice filar, ha tentato l’arrocco con re Sangiovese, ma è stato sopraffatto dalle birre Baltic Porter e si è arreso alla vodka. Perito Capotecnico Industriale in giro per il mondo, non si direbbe un “signor no”, eppure lo è stato finché non l’hanno ficcato a forza in pensione da dove però si vendica scrivendo di vino in diverse lingue per dimenticare la bicicletta da corsa, forse l’unica vera passione della sua vita, ormai appesa al chiodo.