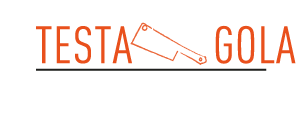#ricettedaleggere. Leggete il testo senza chiedervi in anticipo chi sia l’autore (lo troverete indicato alla fine). Leggete con quanto amore e dedizione ne parla.
Radici di casa che si aggrappano alla terra e che vanno conservate per nessun altro motivo che la gioia di riviverle. Per questa parmigiana servono tre fuochi, il sole la frittura, il forno. Un piatto di festa, di cucina modesta, preparato secondo antichi rituali.
“Il sole che asciugava le fette, la frittura in olio, la perfezione in forno”.
L’autore ha carpito la ricetta alla mamma e alla zia, Emma e Lillina. “Me ne fecero erede per commozione di fronte al mio entusiasmo per quel piatto. Le pietanze sono l’eredità, passaggio di bocconi e cure. Conservano un posto a tavola agli assenti. Le generazioni si staccano una dall’altra per via alimentare, mangiano altro per desiderio di essere altro. Io tento di mangiare qualcosa di uguale, per gusto, per affetto”.
“Non devono mancarmi in nessun mese. Senza parmigiana di melanzane un mese è in esilio. Perché la pietanza mi stabilisce al suolo, mi pianta il Sud nel piatto: la sua buccia lucente, sfacciatamente scura di sole assorbito, il chiaro di dentro che va dorato in padella. Le taglio per lungo sul legno che ha venature a vista, le metto nello stesso verso, così per simmetria. A chi cucina serve un po’ di geometria, tiene compagnia, dà fiato ai gesti. Uso un’arma, una lama spagnola esagerata rispetto alla resistenza della melanzana. Mi serve il taglio esatto, non troppo sottile. Ne acquisto un chilo. La distesa di fette va esposta all’intemperia: sta sotto il sole, sotto il suo peso, senza riparo, ombra.
Così espongo la melanzana affettata alla prima cottura, che consiste nel perdere acqua e peso tra una tovaglia e il cielo. D’estate basta un’ora, rigirando le fette alla mezz’ora.
D’inverno, tutto il sole che c’è, perché è al mattino che si capisce se è giorno di melanzane.
Se però mi afferra la voglia della pietanza, in mancanza del sole mi affido alla supplenza del vento. Anche il vento asciuga il mio bucato di melanzane stese all’aria aperta.
Friggo. In una padella nera, anche incrostata, rovescio un lago d’olio che pesca alla profondità di mezza unghia. Non è di oliva, di semi è giusto, per un piatto di cucina modesta.
L’olio si deve spazientire al fuoco, sputare bollicine, allora è pronto per la prima serie: calo le fette a coprire la superficie, senza sovrapporsi.
Ho in mano un forcone a due denti appuntiti. Appizzo, cioè infilzo il bordo di ogni fetta e la rigiro quando si è già abbronzato il suo lato sommerso. Le riappizzo , le riinfilzo, una alla volta lasciandole sospese due secondi a sgocciolare olio. Ne hanno assorbito poco, dopo l’esposizione all’intemperia.
Depongo le fette fritte in uno scolapasta, dove faranno il secondo spurgo.
Nel piatto sottostante si raccoglie lentamente l’avanzo: se non ce n’è quasi, è stata una buona frittura.
La parmigiana è una pietanza riposata, saggia. Cotta e mangiata? Niente. Non sono uova al tegamino. È melanzana, frutto introverso che si sprigiona con indolenza e meditata pausa.
È passata una notte, posso montare gli strati.
Ho svuotato l’olio della padella, ma non l’ho pulita. Rimane un unto di frittura e in quello calo mezzo chilo di pelati a strofinarsi dentro l’avanzo di sapore.
Basta una scottatura dentro la padella, giusto per disfare la consistenza del pelato. Le mie due cuoche antiche mettevano invece il doppio concentrato di una marca locale sopraffina.
Dentro la teglia da forno spalmo col dito un umido di quel pomodoro e sopra ci sistemo il primo strato; melanzane che sollevo dallo scolapasta, ristorate, distese da una notte.
Spargo un cucchiaio di sugo, mezze foglie di basilico, poca mozzarella già asciutta di latte, già munta, una neve di parmigiano appena sfregato, fine del primo strato.
Continuo fino all’ultima fetta scura, cosparsa di rosso, di verde, di bianco, perché la parmigiana di melanzane è un giacimento di quattro colori separati, che al forno fanno alleanza.
L’affido all’ultimo fuoco, bastano duecento gradi, non deve cuocersi ma sciogliere la distanza tra le parti, diventare pietanza. I colori si sono schiusi, l’odore è di paese.
Deve tornare tiepida, arresa com’era prima del forno, allora è lei, la mia. Anche se l’assaggio in giornata, so che l’indomani sarà migliore”.
La ricetta è di Erri De Luca
“Tre fuochi di Erri De Luca”, Edizione fuori commercio per gli amici di Erri De Luca, Napoli, edizioni Dante & Descartes
Photocredit copertina NapoliToday

Friulana di nascita, triestina di adozione. Quanto basta per conoscere da vicino la realtà di una regione dal nome doppio, Friuli e Venezia Giulia. Di un’età tale da poter considerare la cucina della memoria come la cucina concreta della sua infanzia, ma curiosa quanto basta per lasciarsi affascinare da tutte le nuove proposte gourmettare. Studi di
filosofia e di storia l’hanno spinta all’approfondimento e della divulgazione. Lettrice accanita quanto basta da scoprire nei libri la seduzione di piatti e ricette. Infine ha deciso di fare un giornale che racconti quello che a lei piacerebbe leggere. Così è nato q.b. Quanto basta, appunto.