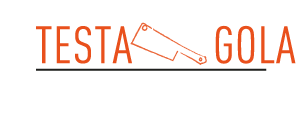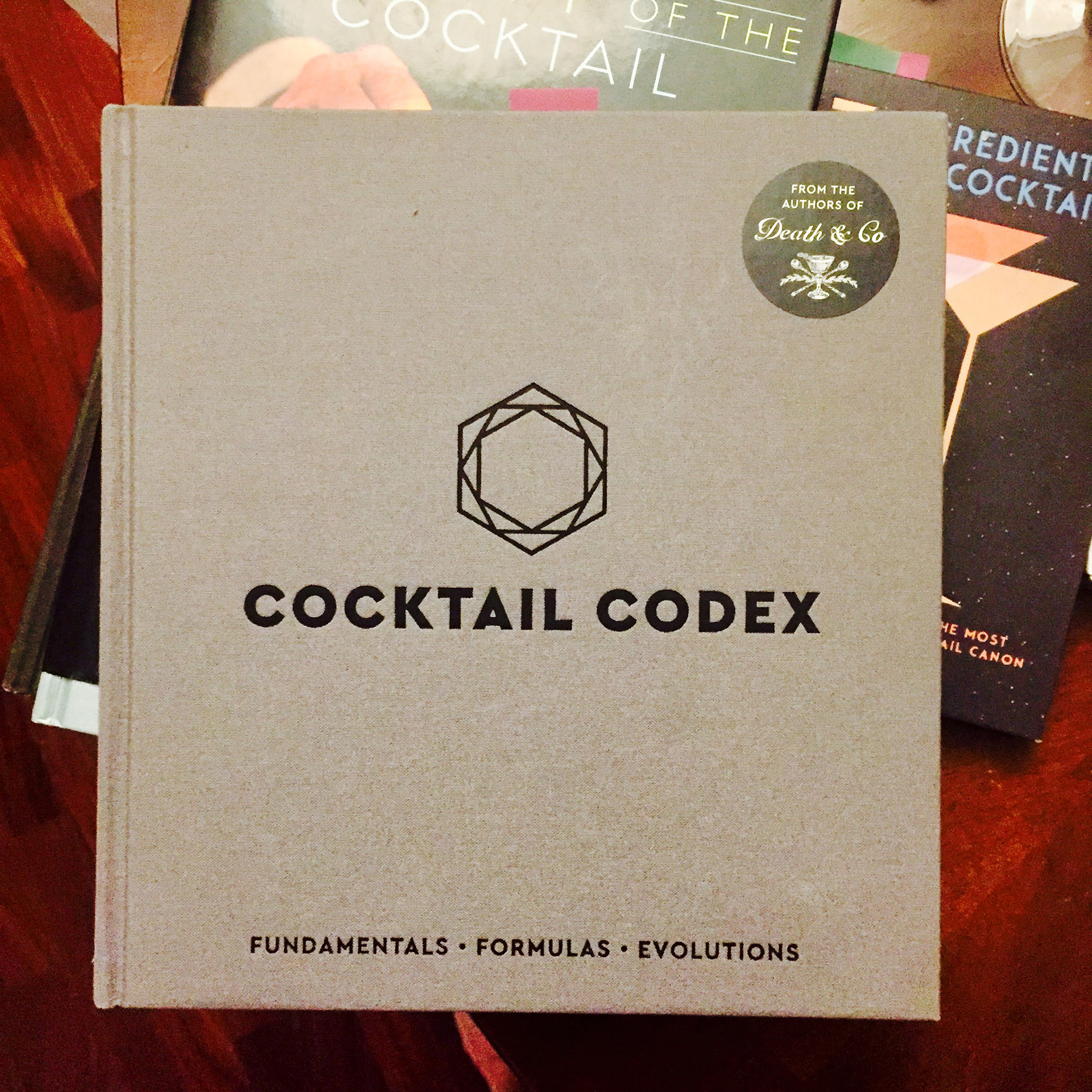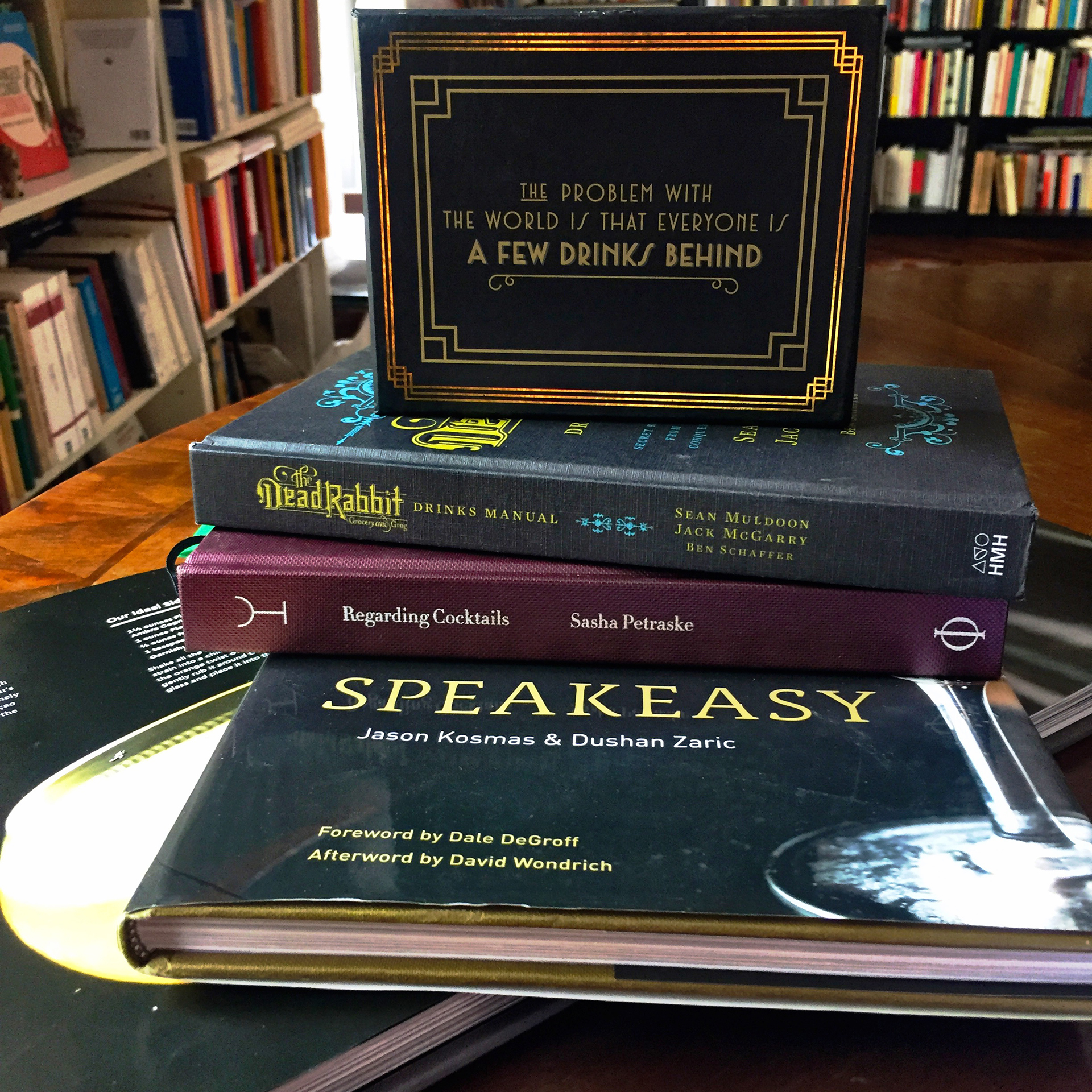Migliaia di ricette, forse centinaia di migliaia, e infinite possibilità di variare, giocare, scompigliare e inventare. Ma come fa un bartender a mantenere un ordine logico nel caos “spiritoso” in cui vive? Come riesce a gestire le richieste più disparate, soddisfare la necessità di essere al passo con le innovazioni del momento e rispettare l’obbligo non espresso ma sempre incombente di dimostrare che conosce la storia del proprio mondo a menadito? E chi bartender non è, eppure rimane affascinato dall’universo notturno degli shaker, degli strainer, dei jigger e delle coppette. Anche il semplice aficionado, l’entusiasta, il flâneur da bancone, il perdinotte. Pure noi, insomma, come facciamo a orientarci davanti a un trionfo di etichette vecchie e nuove, vetri, specchi e bicchieri? Come impariamo a decifrare una terminologia oscura e menù che diventano sempre più criptici: dettagliati fino allo sfinimento o ambigui come un enigma sfingeo?
Le domande sono sconfortanti ma la risposta non è impossibile. Intimamente consapevole della metafisica impossibilità di soddisfare la propria sete di conoscenza, il navigatore di oceani di bitter, vermouth, distillati e liquori non per questo rinuncia a tracciare i confini del proprio orizzonte navigabile; assi e paralleli che lo aiutino a orientarsi tra mareggiate, kraken, pirati del tiki e tritoni armati di barspoon.
Andando indietro nel tempo, ricostruendo la storia per identificare l’origine del “cocktail primordiale”, scrittori e miscelatori hanno gettato le basi per macro-classificazioni che consentano di tenere a mente ricette e sigle oltre la classica, e naif, soluzione temporale: quella che divide i cocktail in base all’ora in cui (per la loro forza alcolica, sostanzialmente) andrebbero bevuti: pre-dinner, after-dinner e sì, any time. Ecco, allora, il metodo classificatorio della presentazione, che distingue i cocktail liquidi da quelli cremosi e i frozen (ovvero quelli frullati con ghiaccio) dai pestati (il Mojito, per esempio); o quello della cosiddetta “capacità”, che elenca, in ordine crescente, shot-drink (il tipico cicchetto o sciottino), short-drink (serviti in coppette), medium-drink (serviti in tumbler bassi, tipo classici bicchieri da acqua) e long-drink (serviti in tumbler alti, o collins).
La pecca di questi sistemi, però, è che servono, sì, a creare delle aree, ma non aiutano a raggiungere lo scopo che ci siamo prefisso, ovvero districarci nella selva mixologica per sapere cosa stiamo bevendo quando ci sediamo al bancone di un bar professionale; troppo generici, questi metodi presuppongono da un lato una conoscenza di ricette, twist e varianti e, dall’altro, non ci dicono nemmeno nulla di specifico rispetto alle caratteristiche che dovrebbe avere (in termini di ingredienti, sapori, proporzioni, struttura) il cocktail da bere a quell’ora piuttosto che a quell’altra, quello che andrebbe servito in una coppetta e non in un rock-glass o quello che andrebbe frullato invece che shakerato. Per molto tempo, il miglior criterio alternativo sembra essere stato quello, deduttivo, della struttura: e cioè, conoscere la struttura base e comune di alcuni “cocktail primari” per ripartirli poi in gruppi, o cluster.
Ma esattamente, cosa significa classificare i cocktail per struttura? Beh, in poche parole, si tratta di studiarne la ricetta e individuare dei minimi comuni denominatori. Ok, ma in termini pratici? In termini pratici andiamo in un cocktail-bar e ordiniamo due drink: un Gin Sour e un Margarita. Ci siete? Bene. Ora chiediamo al bartender che ce li ha appena serviti come sono fatti. A patto di essere andati in un buon bar e avere avuto la fortuna di trovare un bartender con il dono della sintesi e quello della pazienza, scopriremo facilmente che, dal punto di vista logico (cioè, strutturale), sono la stessa cosa. Vogliamo verificarlo? Verifichiamolo. Di cosa è composto un Gin Sour? 1) Gin 2) Succo di limone 3) Sciroppo di zucchero. Le proporzioni? Per ora preoccupiamoci solo degli elementi della ricetta e non della loro quantità, e diciamo 60ml 25ml e 20ml ciascuno – ma su questo torneremo, perché possono variare, non di molto, ma in modo significativo, in base al gusto personale, agli ingredienti utilizzati etc. Dunque, un Gin Sour è composto di un distillato (o base alcolica, o spirito: il gin), di una parte dolce (lo sciroppo di zucchero, nient’altro che acqua e zucchero) e di una parte acida, o aspra (il succo di limone). E il nostro Margarita? Il gentile bartender ci svelerà di averlo preparato con tequila (ovvero un distillato), Cointreau (e cioè un triple sec, o liquore all’arancia, che sarebbe la parte dolce) e succo di limone (la parte acida). Quindi, Gin Sour e Margarita hanno la stessa struttura? Sì, la hanno. Eureka!
A questo punto siate esigenti, ve lo siete meritato: chiedete come si preparano un Daiquiri e un White Lady. Il sintetico e paziente bartender vi dirà che il Daiquiri è fatto con rum bianco, succo di lime e sciroppo di zucchero mentre per il White Lady servono gin, triple sec e succo di limone. Ma allora il White Lady è un Margarita con del gin al posto della tequila, vi starete domandando. Ebbene sì. E il Daiquiri è un Gin Sour con succo di lime al posto del limone e rum bianco al posto del… beh, sì, del gin. Ormai, gli elementi a vostra disposizione sono sufficienti per capire che queste quattro differenti ricette appartengono a un’unica famiglia: quella dei sour (o cocktail agro-dolci, ma non pensate alla cucina orientale, pensate a zucchero e limone). Applicando questo metodo, Gary “Gaz” Regan, un cocktailian bartender con un problema di scrittura, come si definisce lui stesso quando considera l’incredibile mole di pagine che negli anni ha dedicato al bere miscelato. Per Regan, dicevo, le famiglie di cocktail che in questo modo si possono ricostruire sono tante e tanto complesse al loro interno quanto le stirpi bibliche; provo a elencarle nominando per ciascuna famiglia uno o due cocktail rappresentativi:
1) Drink miscelati a base di sidro e birra (Black Velvet);
2) Champagne Cocktail (Bellini);
3) Cobblers (Brandy Cobbler);
4) Drink Franco-italiani (Martini, Gibson);
5) Frozen Drink (Hemingway Daiquiri);
6) Highballs (Jack &Coke, Moascow Mule);
6bis) Florida Highballs (Harvey Wallbanger);
6ter) New England Highballs (Sex on the Beach);
7) Hot Drinks (Irish Coffee);
8) Infusi (Limoncello);
9) Jelly Shots;
10) Juleps (Mojito);
11) Drink alla “Milanese” (Campari, MiTo);
12) Drink “Pestati” (Caipirinha);
13) Pous-Cafés (B52);
14) Punches (Artillery Punch);
15) Snappers (Bloody Mary, Bullshot);
16) Sours (Daiquiri);
16bis) International Sours (Aviation);
16ter) Sparkling Sours (John Colins, Ramos Gin Fizz);
16quater) Squirrel Sours (Irish Squirrel);
17) Drink Tropicali (Mai Tai, Zombie).
Si comincia a intravedere la luce, un metodo, ma diciamoci la verità, diciassette famiglie sono comunque tante (pensate che nelle pagine di altri, meticolosi miscelatori arriviamo anche a trenta); uno sforzo di acribia notevole, ma noi vogliamo qualcosa di tanto più semplice quanto efficace. Un primo indizio ci viene da Sean Muldoon e Jack McGarry, dioscuri irlandesi di uno dei migliori bar del mondo: il “Dead Rabbit” di New York. Per loro, pensando a come costruire il miglior menù del mondo, le famiglie si riducono a dodici:
1) Communal Punch (ovvero là dove tutto ebbe inizio, quando ai superalcolici si aggiungevano spezie, zucchero e acqua mischiando tutto in una enorme, conviviale boule)
2) Punch da bar (quando la convivialità conosce, pragmaticamente, l’individualismo commerciale e fa il suo ingresso sulla scena la soda)
3) Sour e Fizz (del Sour ormai sapete tutto, il fizz è un sour con aggiunta di soda)
4) Fix e Daisy (quando i sour incontrano i cordial e la granatina)
5) Cup e Cobbler (sour con aggiunta prima di frutta – soprattutto frutti di bosco -poi di birra, vino e ghiaccio tritato)
6) Julep e Smash (cocktail con spirito, zucchero e menta)
7) Sling e Toddy (cocktail che prevedono la presenza di acqua e zucchero)
8) Flip, Posset e Nog (Quelli con l’uovo!)
9) Bishop (spezie e vino… rosso, come il mantello di un vescovo)
10) Cocktail (quelli propriamente detti tali: spirito, acqua, zucchero e bitter)
11) Absinthe (quelli… beh, dai, l’assenzio!)
12) I diversi o “per invalidi” (perché… è sempre meglio lasciarsi una via di fuga).
La classificazione dei due ragazzi di Belfast è molto utile, restringe il numero delle famiglie di Regan, ma non tanto da portarle a meno di dieci. Inoltre, ci spiega il come un cocktail sia simile o differisca da un altro ma non ci dice molto sul perché.
Per circoscrivere ulteriormente il campo e, allo stesso tempo, fare un passo avanti nel comprendere se e quanto un abbinamento di ingredienti sia efficace, bisogna fare riferimento a altri giovani pionieri della Grande Mela: gli eretici tradizionalisti del “Death & Co”, i ribelli depositari della tradizione di Dale De Groff e Audrey Saunders (anche in questo caso non siate impazienti, sulla genealogia della mixologiamoderna torneremo presto): Alex Day, Nick Fauchald e David Kaplan. Il loro rivoluzionario schema (tanto rivoluzionario da averlo consegnato, l’anno scorso, a un volume intitolato, né più né meno, “Cocktail Codex”) riduce le stirpi bibliche di Regan a sei modelli la cui cifra distintiva non è data da un’astratta ricorrenza strutturale ma, esattamente, da un cocktail in particolare, uno dei grandi classici: un cocktail, insomma, che tutti conoscono e intorno alla cui formula ruota un complesso, ma ben decifrabile, mondo di varianti e derivati. Se capiamo come funzionano questi modelli-base, dicono i tre, capiamo come si costruisce un cocktail, demistificando il concetto di ricetta (anche su questo tema torneremo) e stimolando la creatività (dopotutto, anche il più istituzionale dei drink prima o poi deve essere stato creato). È un solo eppure significativo passo dal metodo deduttivo a quello induttivo. Ma scopriamo subito le carte. Quali sono questi sei ur-drink? Per Day/Fauchald/Kaplan, il primo sarebbe l’Old-Fashioned, il secondo il Martini, il terzo il Daiquiri, il quarto il Sidecar, il quinto il Whisky Highball e il sesto il Flip.
Secondo i vescovi del “Death & Co”, se impariamo, prima, a conoscere bene la storia, composizione, esecuzione di ciascuno di questi sei cocktail, saremo in grado, poi, di capire – e anche preparare – praticamente tutto quello che ci capiterà di incontrare lungo il nostro viaggio. Ma siccome a noi, dopo un Gin Sour, un Margarita, un Daiquiri e un White Lady, piace un po’ sparigliare, non seguiremo l’ordine esatto dei vescovi del “Death & Co”, ma lo riformuleremo partendo, al prossimo appuntamento, dalla storia misteriosa e un po’ negletta del più trascurato e controverso dei sei: il Sidecar. Cheers Up!

Stefano Gallerani è nato il 4 ottobre del 1975 a Roma, dove vive lavorando in televisione. Suoi articoli e saggi sono apparsi su «Alias», supplemento letterario de «il manifesto», “l’Unità”, “Il Mattino” e “Playboy”. Collabora con le riviste «Il Caffé Illustrato» e «L’Illuminista». Altri contributi sono apparsi su “Nuovi Argomenti”, «Alfabeta2», «Il Giannone», «Allegoria» e «Reportage». Nel 2014 ha pubblicato “Albacete” (Lavieri). Il suo ultimo libro. “A Buenos Aires con Borges” è uscito nel giugno scorso per i tipi di Giulio Perrone Editore.