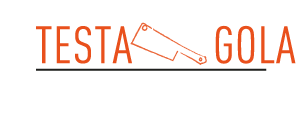Sono nata, come tutti i miei fratelli, nel retro di una drogheria, nel centro di Torino.
A quel tempo il parto in casa era la norma e quando mamma sapeva che era, più o meno, giunta l’ora, faceva venire la levatrice che si installava in casa fino al momento del parto.
La levatrice faceva tutto da sola con la mamma.
I bambini, giunta l’ora del travaglio, venivano spediti da qualche zia ed era papà che aiutava a preparare tutto il necessario: traverse, pezzuole, asciugamani, teli di flanella per avvolgere il bambino.
Tutto perfettamente pulito e stirato predisposto in anticipo da mamma.
L’acqua era scaldata nel putagè che, per chi non lo sapesse, è una stufa a legna che oltre a scaldare la casa, serviva per cucinare, sulla piastra o nel vano forno, asciugare i panni, e fornire acqua calda . Aveva, infatti, una caldaia incorporata con acqua bollente sempre a disposizione.
Alla fine del travaglio, il parto avveniva in un grande mastello dove, appunto, veniva mescolata l’acqua bollente del putagè con quella fredda del rubinetto e l’uscita del bimbo era così più dolce e naturale.
Altri tempi!
Tempi in cui tutto era più semplice e semplificato.
Le merci si vendevano sciolte, dalla pasta allo zucchero, al caffè, la marmellata, l’olio e persino gli “infiammabili”.
Pertanto non c’erano imballaggi perché il cibo non era confezionato, non esistevano buste o bottiglie di plastica e il “vuoto” in vetro si riportava al negoziante
Ricordo il bancone enorme di legno col piano di marmo bianco e una pastaia di legno e vetro, altrettanto enorme con tanti scomparti e cassetti che ospitavano vari tipi di pasta. Un angolo del negozio era riservato al torrefattore.
C’erano 3 vetrine di cui due a cassone. La terza, centrale, alla festa dell’Immacolata, veniva addobbata di raso e fiori con al centro la Madonna, per la processione del quartiere.
La sera, per andare a dormire, si doveva percorrere un passaggio, sul retro del negozio, tra sacchi di yuta colmi di caffè, il bidone dell’olio di oliva e le grandi scatole di latta delle “droghe”.
Le droghe, che oggi chiamiamo spezie, venivano pesate e vendute sciolte su della carta velina. C’era la cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano, il cacao, la “cassia en cana” (una cannella meno pregiata di origine cinese), il pepe bianco e quello nero, la paprika e poi cedro e arancio canditi a grandi pezzi e una pasta densa di limone e zucchero che si prendeva col cucchiaio e che io rubavo di nascosto…
Tutte le spezie, insieme al profumo del caffè, emanavano un profumo esotico, un aroma inebriante che mi è entrato nelle cellule cerebrali fino a renderlo un ricordo olfattivo indelebile!
Con molte di quelle spezie mamma faceva una torta di pere con un’antica ricetta: grattugiava un chilo di pere, aggiungeva un uovo, poca farina, lo zucchero e le spezie: la cannella, il chiodo di garofano, la noce moscata, una bella presa di Saporita, il pepe, il sale, il cacao , il succo e la buccia di limone.
I limoni si compravano al mercato, in piazza, su una bancarella. Li vendeva il papà di Renata Razzetti, la mia compagna di banco in prima elementare.
La torta si cuoceva nel forno del putagè in una teglia rettangolare di alluminio imburrata e cosparsa di pane pesto. Diventava un delizioso dolce al cucchiaio dalla crosticina scura
In negozio si vendevano anche surrogati del caffè: la cicoria tostata vero Franck, la miscela Leone e il malto Kneipp. Ma la droga più in voga a casa mia era il caffè.
C’era sempre, ad ogni ora del giorno una napoletana pronta sulla stufa.: al mattino a colazione, ma anche a metà mattina, poi dopo pranzo e spesso nel latte della sera.
A volte a merenda mettevo sul pane la polvere del caffè macinato, ci versavo un po’ di caffè della caffettiera e spargevo lo zucchero.
Un profumo davvero di casa quello del caffè perché papà era il mago della torrefazione.
Ricordo che un giorno papà prese una manciata di caffè dal sacchetto di juta e aprendo le mani a conca mi mostrò quei chicchi verdi come fossero pietre preziose. Aveva gli occhi luccicanti mentre mi parlava dei paesi lontani da dove provenivano: Nicaragua , Costarica, Kenya , Brasile.. Papà parlava ed evocava in me il mondo intero!
Faceva le miscele dei vari tipi di caffè e poi lo tostava in un grande torrefattore.
Infine, al momento della vendita, macinava il caffè. I due macinini usati da mio padre, quello manuale e quello elettrico ora sono in casa mia. 🙂
Quando papà tostava il caffè io lo sapevo perché, tornando da scuola, il profumo di caffè tostato si sentiva in tutta la via San Donato.
Papà faceva un caffè eccezionale e ne andava fiero. Un caffè dal gusto unico che non assomigliava a nessun altro.
Ora so che un caffè così non nasce a caso. Quello nasceva dalla cura e dalla passione che ci metteva mio padre.
La tostatura andava fatta a bassa temperatura e bisognava capire il momento giusto in cui interrompere la cottura, quindi mio padre controllava la tostatura: ne tirava fuori un campione, controllava e me lo faceva vedere.
Quando infine si sentivano i chicchi crepitare leggermente dall’interno della macchina, significava che il caffè aveva raggiunto il perfetto grado di cottura. Immediatamente papà alzava una leva da cui uscivano come un fiume in piena i chicchi di caffè con un rumore che a me sembrava un chiacchierio. Si raccoglieva in una vasca circolare e papà azionava le pale che servivano al raffreddamento rapido.
Io guardavo il caffè con la stessa meraviglia di mio padre: era bruno, lucido, leggero e aromatico.
L’ultima volta fui io a tostarlo, su istruzioni di papà che ormai era a letto e non poteva più stare in negozio.
Quando gli portai il caffè per la valutazione della tostatura ebbi l’impressione che fosse felice di avermi comunicato la sua passione.