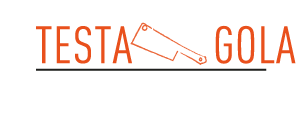No, stavolta purtroppo non si tratta soltanto di uno di quei vinacci svenduti perché difettosi oppure di quelli che puzzano di scarpe vecchie e di vernice perché conservati senza criterio in garage.
Questi sono tutti abbonati da sempre all’impietosa via dello scarico nel lavello non appena stappati, in quanto sono sconsigliabili perfino a un eventuale riciclo in cucina perché rovinerebbero anche le pietanze. Stavolta il disonore di finire impietosamente nel lavandino è toccato a una bottiglia di un vino… ”à la page” e addirittura senz’alcun difetto enologico particolare (badate bene!), una di quelle cosiddette bottiglie tribicchierate, pentagrappolate, pluristellate, insomma podiate ma costosissime. E pensare che ancora qualche anno fa me la sarei forse centellinata con estrema voluttà.
Prima o poi doveva capitare
era nell’aria già da qualche anno. Direi perlomeno da quell’annata 1997 in cui qualcuno ha cominciato a esagerare davvero con estrazioni, densità e aromi che generalmente si definiscono foxy, selvaggi. Eravamo in tre. Abbiamo alzato i calici dopo la classica roteata in coro come si conviene a un panel di degustazione che si rispetti e, dopo un paio di sorsi rumorosamente ossigenati con le labbra ”à cul de poule“, senza nemmeno consultarci e senz’alcuna pietà… li abbiamo svuotati decisamente nel lavandino.
Adesso un po’ mi vergogno di aver scritto, agli inizi della mia avventura con il vino e per alcuni anni ancora, di aromi selvatici invece di aver avuto il coraggio di chiamarli ciascuno con nome e cognome come invece hanno fatto altri e cioè sentori di lettiera, mantello equino, interiora di lepre, nidi di pernice e compagnia bella. La poesia voleva la sua parte, nel pubblico ci sono anche donne e bambini, perciò chiamarli genericamente aromi selvatici faceva un po’ chic senza far venire la nausea a nessuno.
Ma parliamoci chiaro:
gli odori di stabiello (insomma le puzzette) sembreranno pure curiosi e interessanti a qualcuno, ma non saranno mai dei profumi. Come si fa a confonderli con la delicatezza dell’aroma di buona pelle che a volte nobilita un interessante bouquet o con quello di buoni funghi e frutti di bosco che spesso lo accompagnano e che possono sconfinare appunto nel selvatico più spinto e anche oltre, verso quell’eccitante atmosfera d’alcova, monte di Venere o giù di lì?

In quel vino che abbiamo sdegnosamente cassato io avevo sentito il fetore del cinghiale che permea la buca in cui si è scavato la tana. Ne sono sicuro perché nei suoi pressi ogni fine settimana d’autunno vado a raccogliere quei funghi che puntualmente attendono di esser raccolti sotto l’erba non calpestata che li nasconde, ed è un odore molto simile a quello che in Francia chiamerebbero pipì di gatto, quello che caratterizzerebbe un loro Sauvignon, ma all’ennesima potenza.
Un altro, l’italoamericano, aveva sentito il fetore dell’orso bruno che scortica le piante fino a un metro e mezzo d’altezza per grattarsi la schiena e che in Italia chiamerebbero… vitello Marengo, per non dire odore di stallatico. Il terzo, infine, il polacco, aveva sentito l’odore dei bisonti europei che sopravvivono nella puczta del signorile casino di caccia degli Asburgo vicino a casa sua e che assomiglia molto al letame, cioè un po’ più forte, poeticamente parlando, di quel mitico ”merdìn” che invece nobilita i baroli conservati qualche anno al calduccio in solaio per il bisnonno che ci inzuppa i savoiardi, troppo duri anche per le sue gengive ormai orfane di un bel po’ di denti.
Oddìo, abbiamo preso lucciole per lanterne?
No, è che ci sono produttori che esagerano consapevolmente con i brettanomiceti in cantina e ce ne sono altri che l’anidride solforosa no, proprio no, ma quando mai? E magari con fermentazioni favorite da lieviti selvatici, detti anche indigeni, ma in questo caso pure cannibali per favorire lo sviluppo nel vino di un bouquet animale che non è proprio tanto naturale come sembrerebbe. Invece è introdotto, progettato, mercanteggiato come una rarità specialmente in un’epoca come la nostra, dove l’igiene che finalmente comincia a predominare in cantina ha prodotto dei vini molto più sani, quindi solari, floreali e fruttati.
Indietro non si torna, nel bene come nel male.
Non si trovano più gli aromi dei vini piemontesi di quaranta, cinquant’anni fa, non c’è verso e ormai ci ho fatto il callo (e forse è meglio così, per non piangere). Ma mi aspetto qualcos’altro da un’enologia che ormai dispone di quello che vuole per poter fare dei vini grandi anche senza ricorrere ai trucchi.
Quando un panel di degustatori che sa bere (e godere) in ogni parte del mondo vini di ogni fascia di prezzo, da 1, 10, 100 o 1.000 euro la bottiglia purché siano stati fatti con serietà, onestà e dignità, mi getta nel lavandino tutti i calici, nessuno escluso, di una bottiglia che non ha mostrato segni di decadenza, ma soltanto un’esagerazione di estrazione, d’interpretazione, di manovre di cantina, di alchimia enologica adottata per scioccare il palato di qualche scrittore alla moda… c’è da cominciare a preoccuparsi.

Dove sta andando il nostro vino rosso? Cosa berremo tra dieci o vent’anni? Aromi che una volta si trovavano in qualche nota leggera, delicata, di cipria, di rossetto, di liquirizia, di buon tabacco, in qualche vino con i guanti bianchi, oggi ce li ritroviamo a dosi sempre più massicce, direi commerciali, in qualsiasi cosa di rosso che venga imbottigliata. E questo è ancora poco. Sta diventando un pericoloso criterio di scelta perfino la ricerca di effimera potenza in un vino da pasto (che è un’altra cosa rispetto a quella di un vino da sempre prodotto con uve passite) che annebbia fra i fumi dell’alcool anche le sensazioni di chi vi cerca invece fiori, frutti, sogni, amori.
Oggi
in qualsiasi enoteca in cui entrate, provate a fare la somma dei tenori alcoolici delle bottiglie che vi portereste più volentieri a casa: chi lo acquisterebbe ancora un fine Nebbiolo d’Alba di razza con il 12,5% di alcool, profumato, corposo e sublime quando ci sono perfino dei potenti, muscolari e scioccanti Dolcetto (ebbene sì, Dolcetto…) con il 14,5% di alcool a volte nemmeno dichiarato proprio fedelmente in etichetta per non scoraggiare i clienti delle trattorie, e sicuramente a prezzi più abbordabili?
Anche nel tempio di Bacco ci facciamo prendere la mano da qualcosa che non è mai stato e non sarà mai una caratteristica di qualità del vino, ma fa tanto moda: il tenore alcoolico. Che in Italia non ha un limite massimo.
Dovreste vedere
come s’incaz…, pardon, s’incavola Fabrizio Ceccotti dell’azienda Cantarutti Alfieri di San Giovanni al Natisone quando nella valutazione di un vino sente parlare di tenore alcolico. Lui che il vino lo fa senza forzare l’uva, ma accompagnandola delicatamente a fare il mosto, a diventare vino e a maturare in legno quando indispensabile e per tutto il tempo necessario, non si dà pace che ci sia chi valuta il tenore alcolico più alto come una dote di qualità forse anche più importante di altre.
I suoi vini, a volte, possono avere in certe annate anche un tenore alcolico svolto naturalmente e senza forzarlo del 14,5%, ma Fabrizio non lo considera come la base per valutare quei vino. Come dargli torto, visto che ultimamente molti altri vitivinicoltori invece non s’impegnano nell’evitare eccessive surmaturazioni ed estrazioni perché bere spremute di alcool travestite da vino è diventato di moda nei salotti di molte/i influencers (che non esisterebbero senza i deficienters…).

Ma perché questo è stato possibile?
Perché la legislazione enologica e i disciplinari di produzione dei vini non liquorosi non prevedono limiti massimi, ma soltanto quelli minimi, né privilegiano l’equilibrio tra il tenore alcolico e l’acidità.Un vino troppo alcolico, non opportunamente equilibrato, in bocca appiattisce il profilo gustativo, la sua vivacità e produce una improvvisa sensazione di calore, se non una sensazione tattile di bruciore alle papille a cui segue quella della dolcezza tipica del distillato.
Questi effetti dell’alcol
possono essere diminuiti attraverso un opportuno equilibrio con le altre doti organolettiche. Va trovata la giusta armonia con l’astringenza prodotta dai tannini, l’acidità che in maggioranza nasce dall’acino dell’uva e in minor misura durante la fermentazione e il periodo di affinamento, la quantità di sostanze minerali. L’equilibrio diminuisce la percezione dell’alcol in bocca anche se non ne diminuisce la quantità percentuale, rendendola più mite, e questo è importantissimo proprio nello scorcio temporale che il clima sta attraversando, caratterizzato sempre più da stagioni estive piuttosto calde, afose, torride che incidono notevolmente sul ciclo della maturazione delle uve e sullo sviluppo degli zuccheri, aumentandone velocemente la quantità e producendo attraverso i lieviti più alcool in fermentazione.
Quand’ero giovane, mezzo secolo fa
il tenore alcolico era decisamente più contenuto, con un valore medio del 12,5% che allora pochi eccellenti vini superavano per arrivare al 13,5%, tanto che era considerato già medio-alto. Oggi questo valore è considerato medio-basso, Il volume alcolico attualmente presente nei vini da tavola è mediamente del 13,5%, ma ci sono eccellenti vini che raggiungono il 14,5% ed è piuttosto difficile perfino trovare degli ottimi vini con un volume alcolico del 12,5%.
I Francesi
per salvaguardare l’equilibrio nelle loro produzioni AOC e AOCG, curano meglio di noi i limiti ai tenori alcoolici. Nei loro assemblaggi di alta qualità preferiscono destinare a Vin de Pays, in genere con il nome del vitigno di provenienza, molti vini che risultano di tenore alcolico troppo elevato pur di non peggiorare l’equilibrio del prodotto finale. E di parecchi famosissimi Châteaux troverete in commercio i loro vini bandiera AOCG di qualche cru particolarmente apprezzato oltre i trecento o quattrocento euro la bottiglia magari con il 12,5% di alcool, però fatti da grappoli che se non son perfetti poco ci manca, affiancati da bottiglie di Merlot o Cabernet Sauvignon o Syrah da 4 o 5 euro con il 13,5% e oltre di alcool, però fatti da uve che non sono state ritenute degne di entrare in cuvée nei vini migliori della casa.
Per cominciare bene l’anno
non so voi, ma io vorrei bere un po’ meglio e penso proprio che risparmierei pure se comprassi tutto il contrario di ciò che la moda vorrebbe impormi, recuperando una tradizione che renderebbe più felice e allegro anche il padre, il nonno e il bisnonno: un bel vino schietto, sincero, onesto e che non sia difficile, o impossibile, da interpretare come la sella di un cavallo sudato con le sue puzzette. E soprattutto che non finisca per questo motivo nel lavandino.

Ha smesso di giocare in cortile fra i cestelli dei bottiglioni di Barbera dello zio imbottigliatore all’ingrosso per arruolarsi fra i cavalieri di re Nebbiolo e offrire i suoi servigi alle tre principesse del Monte Rosa: Croatina, Vespolina e Uva Rara. Folgorato dal principe Cabernet sulla via dei cipressi che a Bolgheri alti e stretti van da San Guido in duplice filar, ha tentato l’arrocco con re Sangiovese, ma è stato sopraffatto dalle birre Baltic Porter e si è arreso alla vodka. Perito Capotecnico Industriale in giro per il mondo, non si direbbe un “signor no”, eppure lo è stato finché non l’hanno ficcato a forza in pensione da dove però si vendica scrivendo di vino in diverse lingue per dimenticare la bicicletta da corsa, forse l’unica vera passione della sua vita, ormai appesa al chiodo.