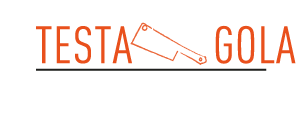L’essere umano è in grado di identificare, banalmente, più di diecimila odori.
Ci sono sicuramente differenze nella sensibilità agli aromi e ai sapori e queste riguardano gli amanti del vino alle prime armi, ma anche gli assaggiatori che fanno parte delle giurie dei concorsi e i produttori di vino professionisti.
Come ho scritto nell’articolo precedente, è molto importante creare una vera ”banca degli aromi” nella propria memoria, anzi non tanto crearla quanto piuttosto organizzarla, perché la maggior parte di questi dati è già lì, nella nostra memoria, anche quando non ci viene facile abbinare i nomi a ciò che i sensi avvertono, creando delle colonnine che distinguono aromi floreali (viola, rosa, gelsomino, ecc.), fruttati (ciliegie, lamponi, ribes nero, ecc.), vegetali (menta, erba appena tagliata, pacciame, ecc.), speziati (vaniglia, liquirizia, pepe, ecc.), aromi animali (cuoio, manto equino, foxy, ecc.), tostati (caffè, tabacco, fumo, ecc.), alimentari (cacao, cioccolato, burro, ecc.) e minerali (idrocarburi, ambra grigia, zolfanello bruciato…).

È vero che, come scriveva in ”Fisiologia del gusto” nel 1825 il padre della moderna gastronomia e gastrosofia, Jean Anthelme Brillat-Savarin, le sensazioni gustative, olfattive e tattili non si trovano disgiunte anche nella descrizione dei sentori di un vino e più in generale dei suoi sapori. Si parla di mélange polisensoriale, ma si può sperimentare la propria capacità d’identificazione sensuale annusando il vino con l’aiuto di uno schema come ho appena suggerito di aromi sistemati in colonne, oppure più professionalmente su ruote (in copertina).
In quest’ultimo caso valga l’esempio della Wine Aroma Wheel, una rappresentazione grafica a ruota degli aromi dei vini sviluppata dalla professoressa Ann C. Noble dell’università di Davis in California dal 1984 al 1987). A un certo punto possiamo anche essere un po’ confusi, ma non appena sentiamo un certo profumo o un determinato odore, improvvisamente tutto diventa chiaro. Lo schema degli aromi ci permette persino di decifrare il termine ”cane bagnato” che gli snob del vino usano spesso e che è semplicemente una delle sfumature aromatiche dello zolfo, che va dall’odore di puzzola fino a quello del cavolo e può arrivare anche a quello del fiammifero bruciato.
In questo schema personale non c’è posto per quegli aggettivi che piacciono invece tanto agli specialisti della descrizione poetica, enigmatica che frutterà loro senz’altro dei buoni incassi perché sa di pubblicità occulta, di raccomandazione, ma che non ci è per niente utile quando non è perfino caricaturale e iperbolica come ci ricorda un famoso dissacrante sketch di Antonio Albanese.
Ci mettiamo invece i nostri rilievi personali fondati sull’esperienza fatta con l’olfatto e con il gusto, cioè i sentori reali come possono essere quelli di fiori d’arancio, confettura di amarene, olive nere, certamente più piacevoli di come potrebbero essere quelli di yogurt e crauti, cavolo insaponato e lettiera di gatto. Possiamo metterci perfino quelli osé, come la parola ”sp..ma” usata da Gino Veronelli per lo champagne Krug del 1976 che scandalizzò una marea di bacchettoni e, se occorre, perfino come quelle dei sentori erotici, tanto è un nostro schema, privato e che deve soltanto aprire la memoria con la maggiore aderenza possibile ai ricordi reali dei nostri sensi.
Con il Gino nazionale quella volta sono nate, ovviamente, critiche e polemiche che ora non vi sto a raccontare e poi, ovviamente, perfino risse e litigi proseguiti sulla stampa specializzata (”lavati le mani prima di toccare il calice!”…). Ecco, questa è una dimostrazione efficace della nostra difficoltà di trasmettere con precisione l’aroma o il gusto di un buon vino agli altri.

I Francesi, che sono avanti almeno mezzo millennio nell’arte di descrivere un vino, usano invece con maggiore ”nonchalance”, senza scandalizzarsi, parole come goudron (catrame), pipì de chat (urina di gatto), fétide (fetido), vulve (vulva). L’uso della metafora concettuale giustificherebbe anche espressioni come ”cipria e sesso sfrenato”, ”coccoina e gambo di ciclamino spezzato”, ”benzina o canfora” e (perché no?)… ”carruba… birmana” se corrisponde veramente a quella che abbiamo gustato durante una gita in quello sperduto Paese dei montanari gurka.
Vanno però evitate comunque tutte le varie pretese poetiche ed enigmatiche di un amante del vino che esprime la sua interpretazione personale della natura del nettare di Bacco e ne canta le lodi. Una performance perfettamente inutile al fine di descrivere un vino quando non si è retribuiti per confezionargli un abito da cerimonia, ma che può strappare soltanto gli applausi della claque. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro schema degli aromi è un calice ampio e… un salto ogni tanto in una profumeria, dal fiorista o in un negozio di alimentari! Piedi per terra, dunque.
Quando giudichiamo che un certo vino bianco ”sa di papaya” non intendiamo riferirci referenzialmente alle proprietà della papaya, non intendiamo dire che tutte le molecole chimiche presenti nella papaya sono presenti anche nel vino. Al contrario, ampliamo la denotazione del concetto papaya per includere quel vino che ci ha mostrato alcuni tratti aromatici affini al ben più complesso sentore della papaya e in particolare quella sua caratteristica dolce-acidula tipica che avevamo in memoria per averla assaggiata, per dirne una, alla fiera degli ”Oh bej! Oh bej!”, che è il mercatino tipico del periodo natalizio milanese dal 7 dicembre, giorno del santo patrono di Milano cioè Sant’Ambrogio, fino alla domenica successiva.
Ma questa analogia resta sullo sfondo e la somiglianza con la papaya è riconoscibile a noi stessi e soltanto dopo quindi che abbiamo individuato il nostro descrittore più vicino al sentore di quel vino per proporlo all’attenzione di altri degustatori, i quali potrebbero non avvertirlo alla stessa maniera o non sentirlo proprio.

Per esempio, quel sentore di pipì de chat (urina di gatto) che universalmente, ormai, quasi tutti trovano nei Sauvignon francesi e non è sgradevole ai più, è causato dalla pirazina, una molecola eterociclica dell’azoto molto presente sulla buccia di quell’uva, inoltre i suoi vari derivati metile, etile, metossile, isopropile e isobutile costituiscono i principali composti aromatici di numerosi altri vegetali come l’asparago selvatico.
Per questo a me personalmente quei vini non piacciono, ma preferisco piuttosto quelli friulani dei Colli Orientali e del Collio nonché i migliori della Nuova Zelanda (non certo quelli della regione del Wairarapa, nei pressi di Wellington, che detengono il record della pirazina…), dove quel sentore è prodotto sì dalla stessa molecola, però è più stemperata, è più simile all’odore delle siepi di bosso. I degustatori più gentili, infatti, per descrivere quello stesso sentore usano la parola bosso invece di pipì de chat.
Esattamente come io non userei nemmeno la parola passerina per descrivere il sentore, il sapore, di ciò che per pudore vi lascio solo immaginare, tanto che per decenni sono sempre diventato perfino rosso nel cercare di arrabattarmi pur di descrivere in qualche modo questo profilo gustativo che con la donna in piena salute è in realtà molto sottile, quasi insapore, lievemente dolce, leggermente sapido, delicatamente acidulo. Mai descritto in presenza di minorenni o di stregoni dell’Inquisizione, però penso che quando si individua un sentore preciso si deve fare come i francesi e cioè non temere di descriverlo precisamente o in qualche maniera comprensibile senza essere volgare, poi ognuno troverà sicuramente il giro di parole giusto e ve lo auguro di cuore.
L’argomento degli aromi e della loro proposta, in generale, è comunque ben presente in tutti i corsi di avviamento alla conoscenza del vino condotti da esperti in materia (discutibili o indiscussi) e, in effetti, è tema di tante conferenze. Il vino come argomento di scrittura o di conversazione provoca scrittori o oratori, li spinge a scalare le fasce culturali riservate all’arte, alla letteratura, alla poesia, ma può anche tradirli e abbandonarli quando cominceranno a parlare di ”mazzi di fiori di campo cosparsi di rugiada mattutina”, di ”legna fresca gettata nell’erba appena falciata”, di ”asfalto riscaldato dal sole nel cortile della scuola” o di quella ”scatola di sigari cubani nascosta nel cassetto dello scrittorio del nonno” poiché strapperanno delle sincere risate, sicuramente cordiali, ma anche qualche ghignata di traverso e non si escludono indignazioni.

Una volta ho partecipato a una degustazione commentata in un lussuoso hotel di un bel parco presso Varsavia, alla quale ha partecipato pure il decano dei commentatori polacchi di vino che non ha mai voluto tradurre dal francese la parola gudron in pubblico perché nelle sale dove l’aveva fatto aveva notato che qualcuno storceva il naso e quindi non si sarebbe mai azzardato ad assaggiare quel vino. C’era anche un giovane amico appassionato di vino, proveniente da un corso per sommelier, con un naso finissimo, curioso, indagante, che aveva ascoltato con grande attenzione le osservazioni di tutti i colleghi, però all’incirca ogni quarto d’ora gli si leggeva in faccia una violenta ondata di riprovazione.
Ero curioso di sapere quale fosse il problema e quando sommessamente gli ho chiesto di spiegarmelo, mi ha risposto che non capiva niente di quello che il presentatore dei vini leggeva da un foglietto tremolante. ”Ho pagato per assaggiare vini veri, fatti con l’uva e mi piacerebbe conoscerne la storia, il territorio in cui nascono con suoi paesaggi, la flora, la fauna, le persone che li fanno, i problemi che hanno e come li risolvono, voglio sognare cosa c’è in bottiglia e invece tutto quello di cui sento parlare sono soltanto prugne, albicocche, ciliegie, lime, passiflora e nient’altro! Sarebbe più corretto dire che profumano di quell’uva, soltanto di quell’uva senza arrampicarsi in descrizioni tra l’altro confuse tra sentori, odori e profumi al naso o in bocca o nel retrogusto”.
Questo è, ovviamente, un caso estremo. La maggior parte dei consumatori di vino è consapevole che l’aroma dell’uva fresca è piuttosto raro nei vini (ogni Moscato però ne ha sempre almeno un po’), anzi è abbastanza facile percepire una vasta gamma di aromi di altri frutti anche senza essere uno specialista. Tuttavia, è molto più difficile convincere un profano che infilando il naso in un bicchiere si possono sentire chiodi di garofano, burro, peli di cane o piscio di gatto e che queste non sono invenzioni degli assaggiatori, ma aromi autentici e reali associati a specifici composti chimici presenti sia nel vino che negli elementi della realtà che ci circonda. I chiodi di garofano contengono eugenolo, una molecola chimica della serie dei terpeni volatili, perciò non può che odorare di eugenolo. Il vino invecchiato per un anno in una barrique di rovere francese odora di chiodi di garofano perché il legno di quella botte contiene lo stesso eugenolo dei chiodi di garofano.
Quindi, se prendessimo delle posizioni scientifiche, ma estreme, cercando di allontanarci il più possibile da ogni poesia e da ogni imbarazzo per certi sentori, dovremmo descrivere un vino così: ”Aroma moderatamente intenso di 1-(4-idrossifenil )-3-butanone con tracce di beta-citronellolo. Gusto moderato di metossipirazina, con notevole acetato, lattone d’acero, con forti elementi di eugenolo, effetto della miscelazione del fenolo con 4-etilfenolo e 2-acetilpirazina”. Proprio così. E sarebbe ineccepibile. Ma chi lo comprerebbe dopo una simile descrizione? Pertanto, un po’ di poesia non farà male. L’uomo è una creatura così profondamente handicappata in termini di olfatto che dobbiamo fare appello alla sua immaginazione sensuale attingendo a schemi più semplici dall’ambiente a lui più vicino. Riusciamo a imparare meglio qualcosa sul vino quando decifriamo il suo bouquet senza formule chimiche e apprendiamo che ”al naso, chiare note di lamponi e di delicati petali di rosa; in bocca pepe verde con un tocco di funghi, liquirizia e muschio, sfumature di chiodi di garofano, cuoio e pane tostato dal lungo invecchiamento in rovere; il finale è leggermente ammandorlato e persistente”. O no?

Ha smesso di giocare in cortile fra i cestelli dei bottiglioni di Barbera dello zio imbottigliatore all’ingrosso per arruolarsi fra i cavalieri di re Nebbiolo e offrire i suoi servigi alle tre principesse del Monte Rosa: Croatina, Vespolina e Uva Rara. Folgorato dal principe Cabernet sulla via dei cipressi che a Bolgheri alti e stretti van da San Guido in duplice filar, ha tentato l’arrocco con re Sangiovese, ma è stato sopraffatto dalle birre Baltic Porter e si è arreso alla vodka. Perito Capotecnico Industriale in giro per il mondo, non si direbbe un “signor no”, eppure lo è stato finché non l’hanno ficcato a forza in pensione da dove però si vendica scrivendo di vino in diverse lingue per dimenticare la bicicletta da corsa, forse l’unica vera passione della sua vita, ormai appesa al chiodo.